Al contrario della pancreatite acuta processo che insorge in maniera rapida e dà una serie di sintomi che si sviluppano in un breve lasso di tempo, la pancreatite cronica è una patologia che richiede anni per svilupparsi, ma può avere delle conseguenze altrettanto gravi. I due tipi di pancreatite hanno degli aspetti in comune, ma presentano tra loro una sostanziale differenza: la pancreatite cronica, infatti, è un processo irreversibile che porta ad una progressiva distruzione del pancreas con compromissione delle sue funzioni.
Sappiamo che il pancreas esplica due tipi di attività: l’attività ormonale, che controlla, ad esempio il corretto equilibrio degli zuccheri nel sangue (pancreas endocrino) e l’attività digestiva, con produzione e secrezione all’interno del tubo digerente del succo pancreatico, ricco di enzimi digestivi che si occupano della digestione del cibo (pancreas esocrino). Vedremo quali sono le conseguenze della perdita di queste funzioni in seguito alla distruzione del pancreas a causa della pancreatite cronica. La pancreatite cronica viene definita una malattia multifattoriale, ovvero sono molteplici le cause che concorrono alla sua insorgenza. L’abuso di alcol è tradizionalmente riconosciuto come la causa più frequente di pancreatite acuta. Numerosi studi epidemiologici hanno accertato che l’alcool è responsabile di circa il 50% dei casi di pancreatite acuta negli Stati Uniti. Altri studi, ipotizzano delle percentuali anche più alte nei Paesi industrializzati. I meccanismi attraverso cui l’eccesso di alcool sia in grado di indurre la pancreatite cronica non sono completamente noti, anche perché emerge che meno del 10% delle persone affette da alcolismo sviluppano una pancreatite cronica. In particolare, non sono state identificate né la quantità di alcool necessaria ad indurre una pancreatite cronica né una dose al di sotto della quale l’abuso di alcool non esponga al rischio di sviluppare una pancreatite cronica. Si parla, comunque, di un “abuso” per periodi di tempo prolungati (anni).
Altri fattori di rischio o cause sono rappresentati da fumo di sigaretta, alcuni farmaci, fattori genetici, malattie autoimmuni (malattie in cui l’organismo, per una sorta di “difetto di regolazione” dirige le sue difese immunitarie contro se stesso) e alterazioni metaboliche che portano ad aumento di calcio o grassi nel sangue. Anche ripetuti episodi di pancreatite acuta possono portare allo sviluppo della pancreatite cronica. Per una percentuale abbastanza alta di pancreatiti croniche, circa il 10-30%, non è possibile ritrovare una causa certa. Si parla, in questo caso, di pancreatite cronica idiopatica, ovvero senza una causa certa riscontrabile.
In molti casi la pancreatite cronica, almeno nella sua fase precoce, non dà sintomi evidenti oppure tali sintomi vengono confusi e sottovalutati dal paziente. Il processo di distruzione e sostituzione con tessuto fibroso o cicatriziale del pancreas richiede in genere anni per svilupparsi, per cui alcuni sintomi insorgono progressivamente e possono non essere notati. Inizialmente le modifiche a carico del pancreas possono essere rilevate soltanto con esami radiologici, a volte effettuati per altri motivi. I sintomi tipici della pancreatite acuta sono il dolore, l’insufficienza pancreatica e il diabete.
Il dolore è presente in circa l’85% dei casi di pancreatite cronica conclamata. Si tratta di un dolore che in genere insorge dopo i pasti (quando il pancreas è maggiormente sollecitato a produrre gli enzimi digestivi) ed è localizzato nella parte alta e centrale dell’addome. Si associa spesso a nausea e vomito ed è estremamente variabile per durata, localizzazione, caratteristiche e intensità.
Gli altri due sintomi sono una conseguenza della compromissione delle principali funzioni del pancreas. La distruzione della ghiandola pancreatica provoca la cosiddetta insufficienza pancreatica una condizione che è una conseguenza della perdita di capacità del pancreas di produrre gli enzimi digestivi in quantità adeguata a garantire una digestione efficace. La mancata produzione di tali enzimi porta all’impossibilità da parte del tubo digerente di assorbire i cibi introdotti con la dieta a causa della loro mancata scomposizione in particelle più semplici, finendo per dare un malassorbimento. Il segno più caratteristico dell’insufficienza pancreatica è rappresentato dalla cosiddetta steatorrea, ovvero il riscontro nelle feci di residui di grassi introdotti con la dieta e non digeriti a causa dell’assenza degli enzimi digestivi adeguati. Le feci in questo caso assumono un aspetto molto tipico che permette al medico di avanzare il sospetto diagnostico di pancreatite cronica. L’insufficienza pancreatica si manifesta in genere negli stadi avanzati di pancreatite cronica perché il pancreas è un organo molto efficiente e affinché compaia la steatorrea bisogna che la sua capacità di produrre gli enzimi atti a digerire i grassi (lipasi) scenda al di sotto del 10-15% della sua capacità normale.
Altro sintomo della pancreatite cronica conclamata è rappresentato dal diabete, condizione caratterizzata da un eccesso di zuccheri nel sangue. Tale patologia è una conseguenza della perdita della funzione endocrina del pancreas che in questo modo non è più in grado di produrre, tra l’altro, l’insulina, l’ormone che controlla e regola, appunto, il livello degli zuccheri nel sangue.

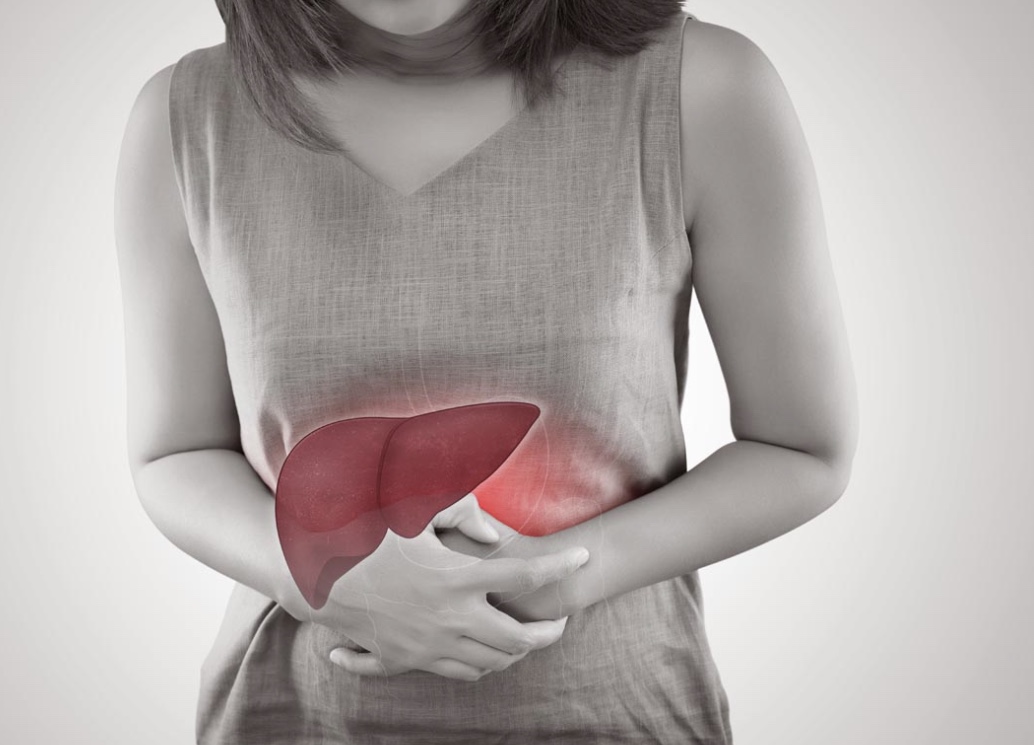






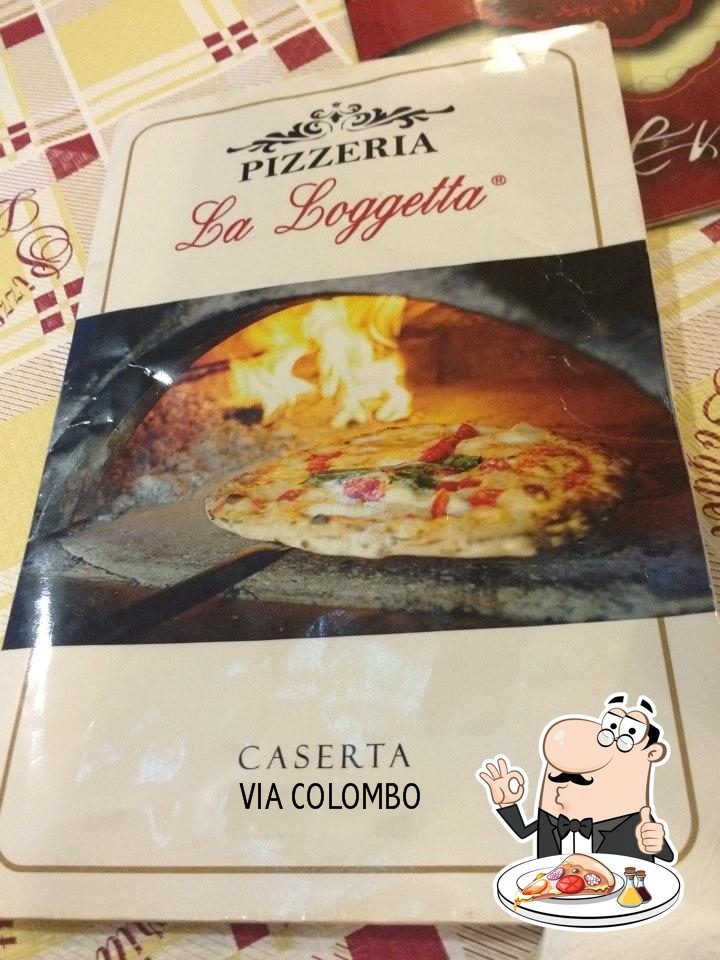





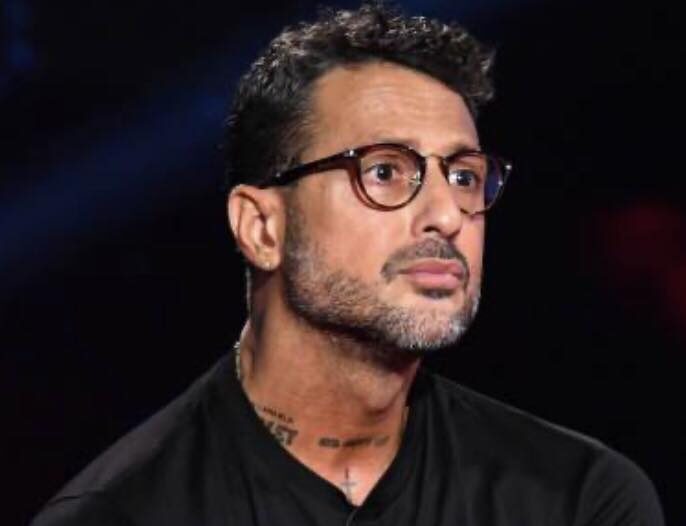

Lascia un commento