Incubo liste d’attesa: 10 milioni di italiani ricorrono di più al privato e 7 milioni all’intramoenia perché non possono aspettare. E se esami e visite inutili riguardano più di 5 milioni di persone, intasando inutilmente le strutture pubbliche, la maggioranza degli italiani sono contrari a sanzioni ai medici di base.
I dati Istat confermano che per le famiglie e gli individui più fragili la spesa farmaceutica rappresenta la parte più consistente del budget destinato alla salute in generale. Detto in altre parole: chi è in condizione di povertà sanitaria ricorre al farmaco molto di più che ad altri servizi sanitari come per esempio la prevenzione e le cure specialistiche, in quanto queste ultime sono ancora meno sostenibili dal punto di vista economico.
Una famiglia su sei risparmia sulla spesa per la salute
Il fenomeno della povertà sanitaria non è una esclusiva delle famiglie indigenti. Negli ultimi quattro anni infatti la diminuzione della spesa per la prevenzione e, in certi casi, la rinuncia totale a visite mediche e accertamenti periodici di controllo preventivo (dentista, mammografie, pap-test, screening oncologici) riguarda una famiglia italiana su sei.
E se una famiglia che non vive una situazione di grave crisi economica sceglie, la maggior parte delle volte, di rivolgersi alla sanità pubblica, una povera rinuncia anche a quella. E la ragione non è solamente economica: troppo spesso incide il vivere in aree del Paese con una oggettiva mancanza di servizi sanitari, territori dove la carenza del pubblico è compensata unicamente dal privato. Inoltre, la possibilità di rivolgersi a strutture sanitarie convenzionate, con programmi dedicati ai nuclei con redditi fragili, richiede l’accesso a informazioni e il supporto di reti di prossimità che spesso mancano proprio nelle aree dove vi è più necessità. E quindi non vengono sfruttate.
Le cause della povertà assoluta
Perché in Italia è così diffusa la povertà? Il rapporto Condizioni di vita in Europa di Eurostat sostiene che le principali ragioni vanno cercate nella stagnazione salariale, ovvero nella mancanza di aumenti di salario o di aumenti non sufficienti a compensare l’inflazione e il costo della vita. Influisce poi il fenomeno del part-time involontario e la crescente precarietà del lavoro che ha portato a un aumento dei contratti a tempo determinato e di quelli a progetto e atipici che hanno salari più bassi rispetto ai contratti a tempo indeterminato.
Il rischio di povertà e di esclusione sociale è acuito inoltre in tutti i casi in cui un individuo soffre la mancanza di qualifiche professionali o di un’istruzione adeguata, vive in condizioni di precarietà abitativa o in aree dove il tasso di povertà è particolarmente elevato ed è maggiore per le donne, i giovani adulti tra i 18 e i 24 anni e i genitori con figli a carico. In Europa la percentuale di donne e uomini esposti a gravi privazioni materiali e sociali a causa di un reddito complessivo sotto la soglia di povertà è del 21,7%. Nel corso dell’ultimo decennio, miglioramenti concreti nella diminuzione delle persone a rischio di fragilità quotidiana per ragioni economiche si sono verificate in Grecia e in Romania. Mentre in 10 paesi membri, tra cui l’Italia, c’è stato un peggioramento aggravato ulteriormente dall’emergenza sanitaria. Mediamente in UE non c’è stato alcun cambiamento di rilievo nella diminuzione delle persone e delle famiglie a rischio o già in condizioni di povertà estrema.














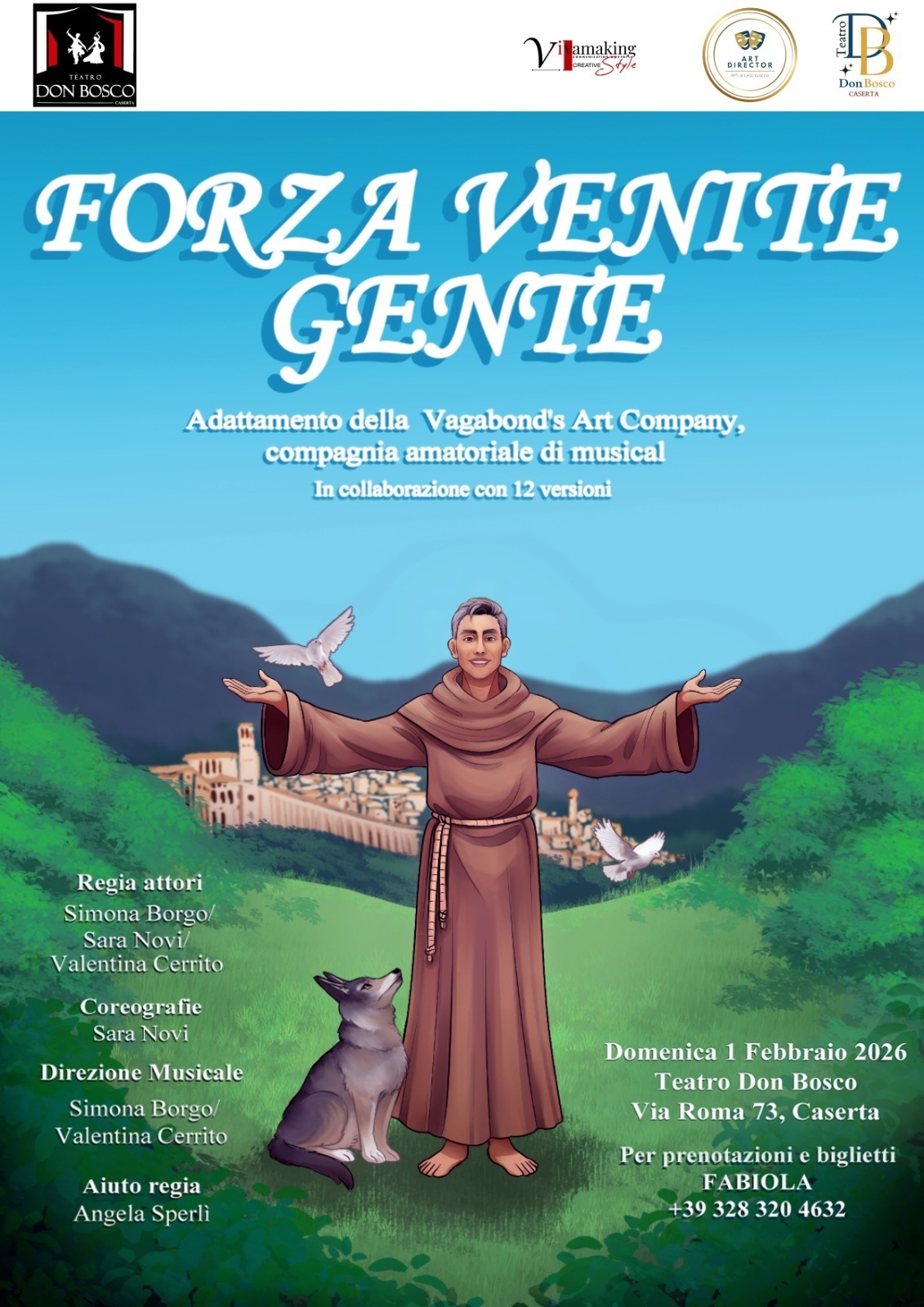

Lascia un commento