Per assicurarne la pacifica convivenza, nell’età contemporanea la liberal-democrazia si è attestata sulla teoria della libera concorrenza tra culture.
E’ stato questo il postulato fondamentale della “società aperta” che, inevitabilmente, ha portato con sé la convinzione che le culture, competendo fra di loro, siano destinate a ibridarsi, ad arricchirsi, a trovare spontaneamente delle sintesi. In ultima analisi a migliorarsi, perdendo la loro purezza originaria per assumere quanto di buono e di valido vi è in quella del vicino.
Queste convinzioni, di per sé inoppugnabili, scontano tuttavia un ottimismo di fondo. Veicolano di fatto una visione spensierata della realtà che, portata ai suoi estremi, non ha mancato di prospettarsi come ingenuo positivismo. Tale dinamica, per ragioni intuibili, si è prodotta con più evidenza in quella fase della storia del mondo in cui la fine del comunismo sovietico, il superamento della divisione del mondo in blocchi contrapposti, l’avviarsi di quel processo comunemente noto come “globalizzazione” hanno fatto immaginare che ci si stesse avviando verso una fase di pacifica evoluzione che avrebbe portato la pratica liberal-democratica a diffondersi senza eccessive scosse telluriche. Sicché i sintomi di nuove conflittualità planetarie sono state scambiate, dai più, per semplici scosse di assestamento.
Non è difficile, a questo punto, comprendere cosa sia cambiato da quella fase ancora sufficientemente prossima della nostra storia, di tale portata da mettere in dubbio un così ben radicato ottimismo di fondo, inducendo %0Ai meno tetragoni a un ripensamento della teoria della società aperta, almeno in alcune delle sue parti. Restando sulle linee generali, la si potrebbe mettere così: è accaduto che il processo di globalizzazione proseguendo il suo corso, accanto ai suoi indubbi vantaggi, ha mostrato anche tutte le sue difficoltà e le sue aporie.
In campo economico, l’intervento di nuovi competitori mondiali sta spingendo a ripensare alla possibilità che nel mondo globalizzato il mercato si possa sviluppare libero da vincoli e senza tener conto delle condizioni di produzione, in alcuni casi assolutamente incommensurabili. Si può dubitare – e io ne dubito – che, a tal fine, la reintroduzione di dazi possa sortire tutti gli effetti auspicati. Ma non si può certo negare che essi, se assunti per periodi temporanei e a livello europeo, possano offrire il tempo e la possibilità per opportune revisioni del nostro sistema produttivo. E ancor meno si potrà negare che il consumatore abbia il diritto di essere informato se la pasta che mangia è stata prodotta grazie a una partita di grano giunta dalle zone di Chernobyl ovvero coltivato con il rispetto di norme volte ad assicurarne la salute.
In ambito strategico, il superamento dell’equilibrio bipolare ha decretato la fine delle dinamiche di sottomissione e di assorbimento dei conflitti minori da parte di quello principale tra super-potenze. Ciò ha tra l’altro prodotto alleanze contro l’Occidente fino a qualche tempo fa inimmaginabili: si pensi solo a quella tra il mondo islamico integralista e il mondo islamico secolarizzato: tra Bin Laden e Saddam Hussein, insomma.
Anche l’ambito delle culture è stato, infine, interessato da questo generale processo di ricatalogazione dei conflitti. Su questo terreno si sono riattualizzati dissidi e scontri che la storia riteneva essersi gettata dietro le spalle, portando qualcuno di assai previdente a prevedere delle vere e proprie “guerre di civiltà”, senza per altro auspicare in alcun modo quest’esito.
Tutto ciò ha imposto ai liberal-democratici non spensierati o dogmatici di rivedere alcune delle loro certezze. Essi, per forza di cose, in quest’opera di revisione sono dovuti partire dal ripensare il rapporto tra religioni e culture. Nessuna persona di buon senso e appena acculturata dubita, infatti, che tale rapporto si trovi alla base dei processi di civilizzazione così come si sono sviluppati dalle origini dell’esperienza umana. Non di meno, però, in molti hanno ritenuto che l’indagine intorno a quel nesso fondamentale potesse ormai darsi per scontata e saltata a pie’ pari. In Occidente, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, si era infatti ritenuto che la modernità dovesse portare con sé un processo di progressiva secolarizzazione il quale, a sua volta, avrebbe reso il fattore religioso sempre meno influente nella storia degli uomini.
La rinascita del sacro che a partire degli anni Ottanta – e con più evidenza dagli inizi del nuovo secolo – si è manifestata non solo ma anche nel mondo Occidentale, per i più ha costituito una sorpresa. Essa ha spinto i meno pigri a rivisitare paradigmi consolidati e a riaprire capitoli d’indagine che apparivano ormai esauriti.
E, per quel che concerne il nostro tema, tale riconsiderazione non ha potuto fare a meno di prendere le mosse da un primo e fondamentale elemento: le religioni, a differenza delle culture, non si ibridano. Se lo fanno, finiscono inevitabilmente per tradire se stesse. Esse – in particolar modo se si tratta di religioni rilevate -, hanno i loro precipui dogmi di fede, che si riflettono in riti e simboli. Possono perciò dialogare, per sforzarsi di trovare quella comune ragione che le ispira. Possono convivere e debbono rispettarsi. Ma non possono confondersi né tanto meno relativizzare le rispettive verità, mirando a una sintesi comune. Se sono religioni vitali, poi, continueranno a influenzare le culture di riferimento, impedendo che queste s’inaridiscano e che, invece d’influenzarsi sanamente a vicenda, si facciano assorbire, fino al punto di soccombere.
E’ a questo punto che per la liberal-democrazia nascono problemi inediti. Infatti, se la libera concorrenza non è più in grado di assicurare la pacifica competizione tra culture differenti, cosa sarà necessario sostituire ad essa? Di fronte a questo quesito io ritengo che il binomio “liberal-democrazia” sia destinato a scindersi e i suoi adepti costretti a scegliere di privilegiare l’uno o l’altro termine.
Per coloro i quali tengono più alla democrazia che alla libertà, dato un processo determinato, l’esigenza prioritaria resta sempre quella di assicurare una posizione di eguaglianza formale tra i soggetti protagonisti di detto processo. Essi per questo, al cospetto della difficoltà prospettata, sono ricorsi a due soluzioni apparentemente opposte ma in realtà assai più simili di quanto si possa immaginare, almeno per quanto concerne gli effetti prodotti.
Alcuni hanno cercato d’anestetizzare l’influenza dell’elemento religioso, che è quello che rende impossibile forzare la sana ibridazione culturale per trasformarla in un più radicale processo di relativizzazione della verità. A tal fine è tornata utilissima una teoria d’origine giacobina, per la quale la religione deve essere considerata un fatto inerente la sfera privata, da gestire nel chiuso della coscienza individuale e, in ogni caso, da non far intervenire all’interno dello spazio pubblico. E’ quanto è stato proclamato nella Francia chiracchiana, ad esempio, con il “rapporto Stasi”, che ha vietato l’ostentazione di ogni simbolo religioso. I risultati sono stati disastrosi. E’ apparso chiaro come oggi resuscitare una religione di stato sovraordinata rispetto alle religioni rivelate risulti, ancor più che discutibile, impossibile. Le crisi endemiche nelle banlieu sono state anche delle insorgenze identitarie che lo statalismo “alla francese” non è stato in grado di assorbire e neppure di contenere. Esse, tra l’altro, hanno chiarito come un bisogno di identità che non smarrisca il rapporto con le proprie , anche religiose, rappresenta oggi un fattore che non svanisce neppure con il succedersi delle generazioni.
Altri, cercando un’alternativa a quell’elemento di autoritarismo comunque insito nella soluzione francese per il troppo potere concesso allo Stato centrale, hanno cercato la soluzione nell’applicazione della teoria del “multiculturalismo”. Hanno cioè risolto il problema dell’eguaglianza sostanziale tra le diverse culture vietando di gerarchizzarle e stabilendo, per questo, che esse abbiano il diritto di operare l’una accanto all’altra, con i propri valori di riferimento e le proprie regole interne, procedendo parallele pur se inserite in un medesimo contesto statuale. E’ stata questa la soluzione a lungo praticata nel Regno Unito, fino a quando una Commissione incaricata da Tony Blair non ha revisionato in profondità tale pratica ritenuta “un incubo” per i risultati ai quali aveva condotto. Questi esiti sono stati disastrosi in particolare dal punto di vista dell’integrazione. Le differenti culture non hanno trovato il modo di legittimarsi vicendevolmente e, quel che è più rilevante, poste al cospetto dell’autorità statuale, le culture endogene non si sono sentite affatto su di un piano di parità con quella esogena. Dal che le manifestazioni di sovversivismo anti-statale, emblematicamente rappresentate dagli zainetti carichi di esplosivo portati in metropolitana, anche in questo caso, da giovanissimi emigrati di seconda, terza e a volte persino quarta generazione.
A questo punto s’impone un quesito: l’Italia che ha la fortuna di essere interessata da meno tempo e, fino ad oggi, in misura certamente minore dal fenomeno epocale dell’immigrazione, può trarre vantaggio dalle esperienze e dagli insuccessi altrui?
Sinceramente ritengo che possa, a condizione però di non sottovalutare le difficoltà che ciò comporterà e, soprattutto, di mettere da parte l’obiettivo dell’eguaglianza tra le culture per privilegiare la salvaguardia (e in alcuni casi la conquista) della libertà possibile.
Salvaguardare la libertà, innanzi tutto, significa non avere neppure l’illusione di potersi sottrarre al confronto con il fenomeno immigratorio a vantaggio di un ideale autarchico. Nella società globalizzata, insomma, l’immigrazione di ampie masse provenienti da culture, religioni, civiltà differenti è una necessità e, entro i limiti di cui si dirà, anche una circostanza positiva. L’ideale di Charles Maurras, che nella cronaca di un viaggio in Corsica riferiva estasiato l’esempio di un’abitazione con cimitero annesso, nella quale la persona compiva l’intero suo ciclo vitale dalla culla alla sepoltura, è oggi null’altro che una bella immagine letteraria: per fortuna!
Tale inevitabile disponibilità, però, diventa più responsabile se si nutre della consapevolezza dell’impossibilità di garantire un’eguaglianza tra le culture che convivono in un determinato contesto, sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale. E ciò per due motivi principali, uno dei quali si riferisce al contesto endogeno, l’altro a quello esogeno.
Per quanto concerne il primo, è necessario prendere atto che i processi d’integrazione, tra uomini così come tra culture, non si scrivono mai su un foglio bianco. Esistono tradizioni, costumi, norme di un determinato contesto e queste meritano rispetto se non si vorranno provocare reazioni di rigetto da parte degli ospitanti.
Ciò vale in modo particolare – e siamo al secondo motivo – allorquando queste tradizioni, questi costumi, queste norme soddisfano meglio una concezione universale dei diritti della persona: quella per la quale, per intenderci, se si condanna la pena di morte lo si fa sia quando occasionalmente essa è applicata in uno stato americano sia quando ogni giorno e in decine di casi è applicata nella Cina ancora comunista. Insomma: abbiamo il diritto e il dovere di ritenere che la tradizione della famiglia occidentale, dal punto di vista dei soggetti più deboli – la donna e i minori -, sia da preferire al matrimonio poligamico. Abbiamo il diritto e il dovere di reclamare la superiorità dello stato di diritto sulla sharia. Così come abbiamo ogni ragione d’essere orgogliosi delle nostre norme di salvaguardia dei lavoratori se confrontate con lo sfruttamento minorile praticato in tante parti dei cosiddetti Paesi emergenti.
Da qui derivano alcune conclusioni agevoli da trarre ma difficilissime da mettere in atto. La prima: per assicurare la convivenza pacifica tra le culture e la loro naturale ibridazione, nessuno può chiedere a chi giunge nel nostro Paese di rinunziare alla propria e tanto meno di convertirsi alla nostra religione. Di contro, sarà nostro dovere fare tutto ciò che è possibile affinché sia messo nelle condizioni di sviluppare la propria vita spirituale anche in una proiezione pubblica. In cambio, però, bisogna non domandare ma pretendere da ogni ospite il rispetto non soltanto della nostra legge ma anche della nostra cultura e delle sue manifestazioni esteriori, con accresciuto rigore nel caso in cui la persona ospitata svolga funzioni pubbliche di carattere civile e/o religioso.
Affinché questo non divenga poi un mero proposito, è necessario evitare che l’arrivo di immigrati in Italia sia indiscriminato, così come è accaduto durante i due anni di governo della sinistra. Per il possibile, è necessario guidare il fenomeno immigratorio tenendo conto non soltanto della provenienza ma anche dell’istruzione e delle funzioni che potrebbe svolgere chi arriva in Italia. Infine, è necessario svincolare l’assunzione della cittadinanza da ogni automaticità legata al trascorrere degli anni, evidenziando così come l’integrazione sia un processo cultuale e non un diritto che si conquista per invecchiamento.
Si tratta, insomma, di capovolgere i capisaldi di una politica così come essa si è sviluppata nel corso del governo di centro-sinistra. Io non credo alla pratica della tabula rasa, per cui il governo che arriva ha l’obbligo di annullare ciò che ha fatto il precedente. Ma in questo campo c’è pochissimo da salvare. Quel che è più importante, c’è un riflesso da sradicare che, per l’appunto, è un riflesso di natura culturale: l’odio di sé, della propria storia, della propria tradizione.
Quell’odio ci fa correre il rischio di non sapere più chi siamo e da dove veniamo. E’ alla base di tanti processi d’involuzione sociale ed è il veleno che potrebbe portarci a disperdere quella disponibilità all’ospitalità che è carattere precipuo della nostra cultura. Perché solo chi è sicuro di sé ed è consapevole della propria identità potrà aprirsi all’altro, potrà comprenderlo e trovare i modi per convivere con lui in pace.











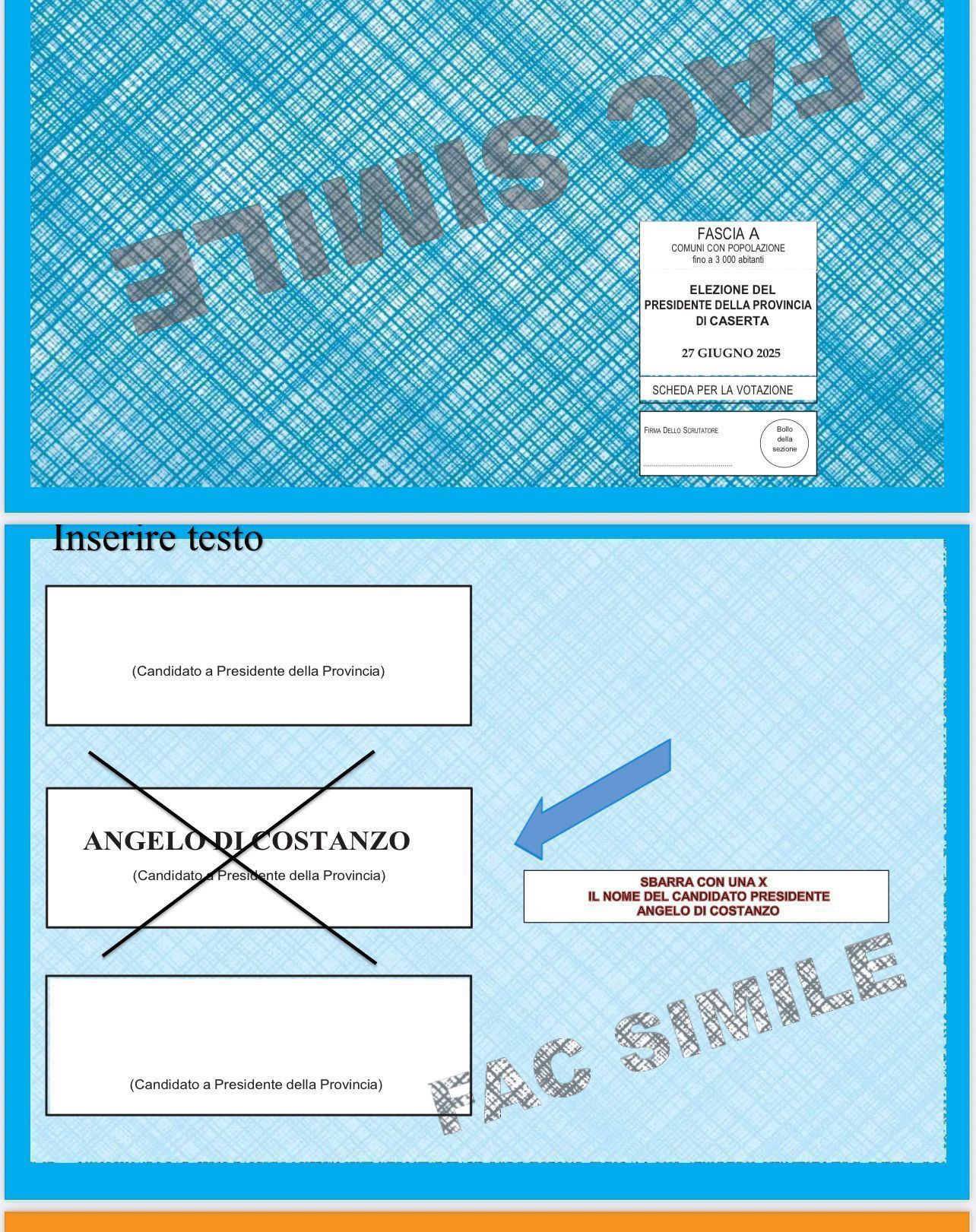




Lascia un commento